Dove stanno andando i centri internazionali di ricerca agricola del CGIAR?

I 15 Centri internazionali di ricerca agricola del CGIAR (Consultative Group for Agricultural Research) sono stati protagonisti indiscussi della ricerca agricola negli ultimi 40 anni. Le varietà migliorate di frumento, di riso, di mais e di molte altre piante coltivate uscite dai loro laboratori e dai loro campi sperimentali sono quelle che hanno permesso di trasformare l’agricoltura arretrata di molti Paesi in via di sviluppo e aumentarne la produttività in quella che è stata denominata la Rivoluzione Verde. Senza gli avanzamenti tecnologici ottenuti e diffusi dai centri del CGIAR, il mondo non sarebbe stato in grado di affrontare la travolgente crescita demografica delle ultime decadi e di produrre alimenti sufficienti a sfamare tutti gli abitanti del pianeta. Questo enorme merito è stato riconosciuto mediante il conferimento del premio Nobel per la pace a Norman Borlaug, miglioratore del frumento e fondatore del CGIAR. Il grande numero di conoscenze, di varietà, di tecnologie sviluppate dai centri del CGIAR hanno trovato applicazione non solo nei Paesi in via di Sviluppo, ma anche nei Paesi industrializzati. In Italia, per esempio, moltissime delle varietà coltivate hanno nella loro genealogia progenitori ottenuti nei centri del CGIAR. D’altronde l’Italia ha contribuito alle attività del CGIAR sin dalla sua fondazione con finanziamenti, ricercatori, e apporti manageriali e tecnologici di grande rilievo.
Solo pochi anni fa, il CGIAR ha intrapreso un vasto processo di riforma, che ha cercato di migliorare l’integrazione delle attività fra Centri Internazionali per accrescerne l’impatto. La riforma si basava su quattro pilastri:
- Rafforzamento della governance del CGIAR mediante l’istituzione del Fund Office e del Fund Council (ospitati dalla Banca Mondiale a Washington, con funzioni di reperimento di risorse e di direzione strategica del sistema), del Consortium Office (ospitato dalla Francia a Montpellier, con funzioni di coordinamento operativo), dell’Independent Science e Partnership Council e dell’Independent Evaluation Arrangement (ospitati ambedue dalla FAO a Roma, con funzioni consultive di programmazione , monitoraggio e valutazione scientifici);
- Coinvolgimento attivo dei beneficiari delle ricerche nella programmazione strategica, mediante l’organizzazione di una Conferenza biennale con i portatori di interesse (Global Coonference on Agricultural Research for Development – GCARD) e la partecipazione nel Fund Council dei rappresentanti di organismi multilaterali (FAO, IFAD, Banca Mondiale), dei fori regionali degli istituti di ricerca agricola, e di qualche Paese in via di sviluppo;
- Organizzazione delle attività di ricerca non più indipendentemente per ogni centro di ricerca, ma in 16 CGIAR Research Programmes (CRPs) ognuno dei quali coinvolge più centri di ricerca e partner esterni e affronta in modo coordinato una grande tematica;
- Adozione di un modello manageriale moderno (Results Based Managment) basato su di una cornice strategica e articolato per Obiettivi Strategici a livello di sistema, con adeguati indicatori di impatto e di risultato per permettere il monitoraggio e la valutazione dei progetti di ricerca.
Il processo di riforma è stato accompagnato da un maggiore impegno dei donatori (Agenzie di sviluppo dei Paesi industrializzati, Banche Regionali di sviluppo, Fondazioni private) che ha portato a raggiungere nel 2014 la soglia di 1 miliardo di dollari di finanziamento per anno.
Tutto bene allora? Dobbiamo compiacerci dei risultati? Purtroppo la riforma non ha dato i frutti sperati: lo sdoppiamento direzionale tra Fund Office e Consortium ha portato ad una serie di gravi conflitti di potere, mentre i Centri di ricerca, privati in parte della loro autonomia, hanno mal digerito la presenza di organi di coordinamento e ne hanno ostacolato il funzionamento. Il sistema è divenuto presto ingovernabile. E qui si affaccia la proposta di una seconda riforma, formulata da una nota impresa internazionale di consulenza, per correggere la prima. I dibattiti che ne sono seguiti sono stati molto aspri, non vale qui la pena di riferirne in dettaglio l’evoluzione, ma conviene piuttosto analizzare brevemente la proposta che appare la vincente. Il sistema CGIAR dovrebbe essere coordinato da un ufficio centrale, con sede presso la Banca Mondiale a Washington, smantellando quindi il Consortium di Montpellier. L’ufficio di Washington dovrebbe essere governato da un Council, composto dai rappresentanti dei 12 più importanti donatori (tra cui non ricade l’Italia). Vengono quindi esclusi dall’organo direzionale sia gli organismi multiraterali FAO e IFAD, sia i rappresentanti dei fori regionali della ricerca agricola e dei paesi in via di sviluppo. La GCARD sarebbe depotenziata e trasformata in un processo regionalizzato con meno spazio per i soggetti esterni. Il sistema CGIAR sarebbe quindi governato esclusivamente dai paesi ricchi e dalle fondazioni private, togliendo ogni voce in capitolo a coloro che dovrebbero beneficiare dei risultati dei progetti di ricerca ed ai loro rappresentanti. L’ufficio di Washington dovrebbe poi contrattare con i singoli Centri di ricerca l’esecuzione dei programmi che i donatori hanno deciso di finanziare, con buona pace del coordinamento, della creazione di sinergie e della integrazione sistemica e multidisciplinare di conoscenze e progetti.
Ci sembra che un CGIAR orientato al soddisfacimento delle priorità dei donatori e non di quelle dei piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo, tradisca il suo spirito fondatore.




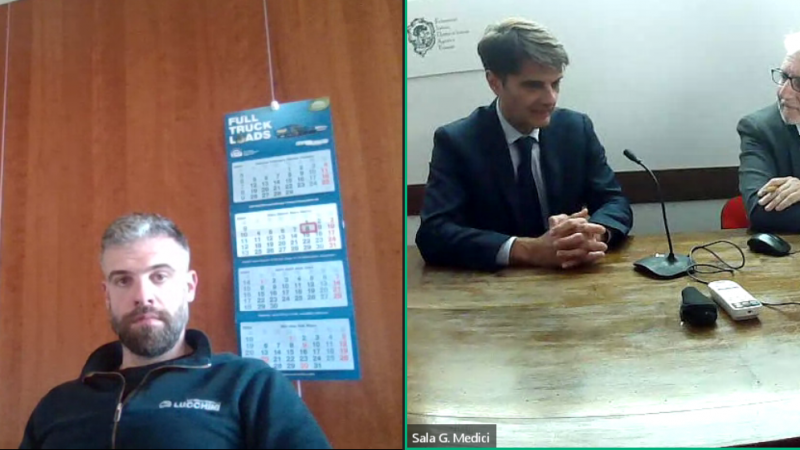


Condivido in pieno quanto scritto da Sonnino. Se dovesse essere applicato quanto esposto, non vi è dubbio che il tutto potrebbe essere orchestrato dalle multinazionali, il cui fine non è certo quello di dar da mangiare agli affamati, ma solo quello di fare soldi!